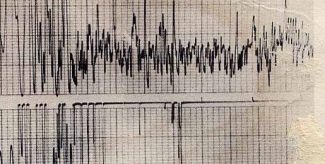Il coronavirus e il ruolo degli ospedali nel propagarsi dell'infezione: la partita tra Veneto e Lombardia
La puntata di due settimane fa era tutta concentrata sull’incertezza che circondava lo svilupparsi dell’epidemia e in particolare, si chiedeva se dovevamo attenderci un futuro lombardo (ai tempi 2259 positivi e 98 decessi) o veneto (407 positivi e 10 decessi) perché i numeri, e quindi le prospettive, sarebbero state completamente diverse.
A quattordici giorni di distanza dall’articolo e a dieci dall’instaurazione della “zona rossa nazionale”, l’incertezza è la medesima e i dati provenienti dalla Lombardia e dal Veneto continuano a mostrare due “mondi” differenti. Era il 22 febbraio quando Conte firmava un decreto riguardante le aree dei due focolai del Lodigiano e di Vo’ Euganeo trasformandole in “zone rosse” da cui non si poteva uscire né entrare. Stesso trattamento, ma risultati opposti: a un mese dall’istituzione di queste due zone rosse la Lombardia ha fatto registrare 2549 decessi, il Veneto 131. Scendendo nei dettagli, nella sola giornata di ieri 20 marzo, la Lombardia ha fatto registrare 381 decessi quasi il triplo di quelli che in Veneto sono stati registrati complessivamente dall’inizio dell’epidemia, venti volte quelli registrati nella giornata di ieri (16).
Riguardo al tasso di mortalità, in Lombardia è stato registrato un morto ogni 4000 (quattromila) abitanti, in Veneto ogni 38.000 (in Alto Adige, a oggi, uno ogni 25.000). Fortunatamente è il dato lombardo ad essere del tutto eccezionale, non solo a livello nazionale. Dei 4032 morti registrati in Italia, 2549 sono lombardi, quasi due terzi del totale. La seconda regione per decessi è l’Emilia Romagna con 640 morti, di cui circa 250 nella sola provincia di Piacenza, il cui capoluogo dista meno di 20 chilimetri da Codogno.
Dati alla mano risulta evidente che da Codogno e da Vo’ sembrano essersi diffusi virus completamente differenti. Perché? Ma, soprattutto, perché nessun altro luogo del mondo, sta registrando tassi di mortalità come quelli della Lombardia? (La sola Madrid sembra aver preso una direzione simile con molti giorni di ritardo. Al momento i morti registrati nella capitale spagnola sono 628 su 1094 totali della Spagna). Non sono domande retoriche, perché una risposta certa a queste domande avrebbe effetti e ripercussioni a livello mondiale. Perché, come noto, tutti stanno imitando il modello di chiusura all’italiana, ovvero un modello cinese partito in ritardo e meno rigoroso.
Lo dimostrano le critiche di alcuni studiosi europei che hanno sottolineato, senza grande successo, come le misure italiane prese dal governo Conte per non intasare le terapie intensive non stiano funzionando. Critiche che hanno un fondamento consistente per quel che riguarda la Lombardia ma non riguardo al Veneto. Sono stati questi dati e queste domande a spingermi a due settimane di ricerca quasi ossessiva per comprendere quali fossero le differenze principali tra Vo’ e Codogno, quali fossero le variabili che potessero spiegare due sviluppi così diversi.
La prima differenza è banale e riguarda la dimensione. Codogno è una città di 16.000 abitanti, Vo’ euganeo di 3.300. Non solo, la zona rossa istituita un mese fa riguardava anche città vicine a Codogno per un totale di circa 50.000 abitanti.
Isolare un’area più piccola è ovviamente più semplice, ma l’altro dato che potrebbe risultare fondamentale lo si può trarre dalla pagina wikipedia di Codogno che sottolinea come la città sia frequentata “soprattutto per la presenza del presidio ospedaliero, delle industrie e delle scuole, che esercitano un forte richiamo sul circondario”. E’ proprio la presenza del “presidio ospedaliero di forte richiamo” a dare un primo contributo alla comprensione del quadro complessivo.
Il secondo riguarda l’accusa di Conte rispetto ai protocolli che non sarebbero stati rispettati proprio in quell’ospedale. L’ospedale di Schiavonia nel padovano, dove sono stati ricoverati i primi malati di Coronavirus, è stato invece chiuso lo stesso 21 febbraio. Come ha titolato il Gazzettino lo scorso 27 febbraio: “Ospedale blindato a Schiavonia: medici e infermieri entrano ed escono ma fanno il tampone ogni volta”.
A questo punto non è nemmeno così importante sapere se le parole di Conte fossero ingiuste (ma chi volesse approfondire può leggere questo resoconto dall’ospedale di Codogno), ma appare ormai chiaro a tutti che in Lombardia «si è verificata la situazione più sfortunata possibile, cioè l’innescarsi di un’epidemia nel contesto di un ospedale, come accadde per la Mers a Seul nel 2015. Purtroppo, in questi casi, un ospedale si può trasformare in uno spaventoso amplificatore del contagio». (Massimo Galli, professore ordinario di “Malattie infettive” all’Università di Milano in un’intervista al Corriere della Sera).
Chiarito questo primo aspetto, cosa ha spinto il virus a seguire, almeno per ora, i confini regionali lombardi arrivando a causare la morte di 695 persone nella sola provincia di Bergamo (oltre cinquanta in più dell’intera Emilia Romagna che segue la Lombardia per numero di decessi). Anche qui può essere utile seguire la strada degli ospedali. Alzano Lombardo è uno degli epicentri dell’epidemia, lì il 23 febbraio scorso, a seguito di due casi positivi, l’ospedale venne chiuso e poi riaperto poche ore dopo e proprio da quell’ospedale pare sia nato il focolaio di Bergamo. Ma per capire situazione, rabbia e frustrazione di chi ha frequentato quell’ospedale nel mese di febbraio è sufficiente un breve viaggio tra le testate locali bergamasche. Ma se queste notizie aiutano a spiegare i motivi della diffusione del virus, non aiutano a comprendere perché il tasso di mortalità sia così alto solo in Lombardia.
A dare una risposta ci ha provato l’immunologo Sergio Romagnani, professore emerito dell’Università di Firenze che, dopo aver analizzato i dati dello studio epidemiologico effettuato dall’Università di Padova a Vo’ Euganeo, ha inviato una lettera alle autorità regionali toscane invitandole a seguire l’esempio di Vo’, e della Corea: “fate il tampone a tutti”. Una lettera, ormai notissima, che è stata ripresa e pubblicata da numerosi quotidiani italiani e stranieri tra cui il britannico “The Guardian”.
Un documento in cui Romagnani prova anche a spiegare le differenze nel tasso di mortalità del virus: “Gli ospedali – spiega – rischiano di diventare zone ad alta prevalenza di infettati in cui nessun affetto è isolato. Il rischio di contagio per i pazienti e tra colleghi rischia di diventare altissimo ed esiste anche il rischio di creare delle comunità ad alta densità virale che sono quelle che, secondo lo studio di Vo’, favoriscono anche la gravità del decorso della malattia”.
Romagnani indica quindi una correlazione tra la “densità virale” delle comunità e la gravità del decorso dalla malattia. Una teoria che sembra confermata dai dati ma che non si comprende su quali basi mediche si fondi. Non restava che contattarlo per chiedergli di spiegarci meglio il collegamento. Questa la risposta: “Non ci sono ancora prove, ma l’ipotesi è che il rimbalzo del virus più volte sullo stesso individuo (a cause delle sue piccole ma numerose mutazioni) provoca malattie più gravi. L’isolamento protegge non solo dal contagio, ma probabilmente rende meno grave l’evoluzione della malattia”.
Dopo dieci giorni di “clausura”, sembra una buona notizia, la prima da tempo. Ma cosa pensa la comunità scientifica della tesi di Romagnani? Come si sta reagendo in Alto Adige rispetto alla sicurezza negli ospedali? Dobbiamo aspettarci dati lombardi o dati veneti? Almeno a quest’ultima domanda si può dare una prima risposta: al momento in Provincia di Bolzano non si registrano picchi paragonabili a quelli lombardi. Sui dettagli e sulle altre domande si tornerà nelle prossime puntate. (segue….)
Massimiliano Boschi