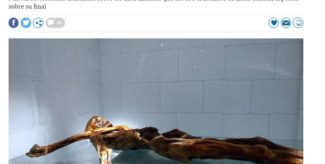Transizioni ecologiche, lupi veri e Heidi finte
Sono nato e cresciuto fantasticando di grandi animali. Dalle passeggiate del Guncina e Sant’Osvaldo, dalle finestre della scuola guardavamo verso il crinale della catena del Roen, al di là del quale si apriva il mondo mitico delle foreste degli ultimi orsi delle Alpi. Della lince si fantasticava di apparizioni in val Slingia, tra Venosta e Mustair, di esemplari provenienti dalla Svizzera, dove erano state da poco reintrodotte (in realtà sulle Alpi Occidentali, quindi molto lontano dai nostri confini). Anche le popolazioni di ungulati erano ai minimi storici. Sulle Alpi, il lupo era ormai un racconto del passato. Così come stava per diventarlo l’orso. I grandi predatori tornavano in quello che gli aborigeni australiani definiscono “il tempo del sogno”.
Nessuno di noi che abbiamo vissuto gli anni ’60 e ’70 nutriva dubbi, allora, che la natura fosse inesorabilmente destinata a sparizione imminente. Quali che fossero i segnali a cui davamo attenzione, il responso non cambiava: il turismo di massa che inghiottiva ogni cosa, sempre più auto, gente e rumore ormai dappertutto; posti dove andavamo per funghi a Sarentino e facevamo alzare in volo i galli cedroni col rumore dei passi sul sentiero, e dove tornavamo l’anno successivo per trovarci, al posto del gallo cedrone, una strada asfaltata e un albergo. Nella Bolzano di quegli anni, dove oggi c’è via Duca d’Aosta io andavo guardare le rane che saltavano tra erba e piccole pozze d’acqua. La TV, in bianco e nero, alla sera confermava tutto: gli esperimenti termonucleari nell’atmosfera, sottoterra e nelle isole del Pacifico; il napalm e l’agente arancio, Seveso e la cloracne; le piogge acide e le morie dei boschi. Perfino a Yellowstone gli orsi mangiavano nei cestini della spazzatura e dalle auto dei turisti. Le canzoni che ascoltavamo, da “Noi non ci saremo” a “In the year 2525” (tradotta con “nel 2033” per necessità di rima) alla «dura pioggia che sta per cadere» (quella del fallout nucleare) di Bob Dylan, non lasciavano scampo. La fine della natura (e forse anche la nostra) era imminente.
Ma non siamo finiti lì e, a partire dagli anni ’80, trasformammo la natura che stavamo perdendo da res nullius, cosa di nessuno e di nessun valore, a merce di massa. Ma nel farlo abbiamo inventato una natura mai esistita. Una che potesse accomodare, sulle Alpi, 120 milioni di turisti all’anno. Abbiamo costruito un mito di popolazioni locali sempre in armonia con l’ambiente, dimenticando secoli di economia predatoria (per fame e necessità, certo) ai danni del bosco – perfino lo strato di terreno superficiale veniva rastrellato e asportato per lo strame nelle stalle invernali, e il legno era il materiale usato per tutto – e della fauna. Invenzione di successo: qualunque valligiano, oggi, dovunque sulle Alpi, può prendere distanze politicamente redditizie dalla malefica città adducendo una differenza che, in realtà, non esiste più (per benessere materiale, tecnologia o aspettative esistenziali e sociali). Monocolture e monoculture si sono imposte: lo sci, il latte sussidiato, gli abeti rossi che crollano come fiammiferi sotto le tempeste. Al turista abbiamo dato l’«alpe bomboniera», definizione finale e letale di Paolo Rumiz. Le montagne di Heidi, insomma: ma quelli sono cartoons giapponesi; una recente e molto realistica riedizione cinematografica svizzera (il grande e scomparso Bruno Ganz, mio concittadino, nella sua ultima interpretazione nella parte dell’Alm-Öhi) mostra chiaramente che le vere Heidi del buon tempo andato dormivano a tre metri dal letame.
Poi, dagli anni ’90 in poi, la transizione ecologica. Né la prima né l’ultima ma, certamente, una transizione vera, non una dichiarata a tavolino. Dopo secoli, la natura – quella vera – ritorna sulle Alpi. Messa in moto dalle politiche ambientali (orso, gipeto, grifone, lince) o rimessasi in moto da sola a causa del diffuso spopolamento montano e rurale (lupo) e da fattori ecologici vari e complessi (castoro, lontra, sciacallo dorato). Certo, agevolata anche da una migliorata gestione venatoria (mai stati così tanti ungulati sulle Alpi da secoli, con le dovute eccezioni). Dal tempo dei sogni di quando ero bambino gli orsi sono passati da 10 a 100; e nelle Alpi si stimano ormai 300 famiglie (“branchi”) di lupi. Avevano ragione, gli aborigeni: più forte sogni, più gli animali torneranno. L’alpe bomboniera improvvisamente deve fare i conti con la natura, ma con quella vera. Pochi, gli esperti, indicano le basi scientifiche per la coesistenza; altri (meno esperti) inventano gli elicotteri che liberano i lupi siberiani, invocano protezione politica e indicono referendum per la liberazione dai grandi predatori, dalla Svizzera al Südtirol; sui social ci si indigna, spesso preferendo ignorare che mamma orsa non è sempre innocua e che salire all’alpeggio e trovare 20 pecore squartate dal lupo non è un bello spettacolo. Ho amici trentini che hanno dedicato la vita al ritorno dell’orso e che per questo si sono “guadagnati” gruppi social di migliaia di odiatori che ne commentano le foto segnaletiche scrivendoci sotto «assassini».
I lupi
I lupi paracadutati e i referendum per liberarci da loro (nel caso, quello vinto dagli anti-lupo nel cantone svizzero del Valais/ Wallis; di cui al momento non si vedono effetti pratici), così come al lato opposto mamma orsa e i cuccioletti, rischiano di farci perdere di vista quello che sta succedendo. Il ritorno di questi animali è simbolo e sintomo apicale di un cambiamento di uso del territorio (land use change, dicono gli esperti) che in tutto l’emisfero settentrionale sta ricostituendo ecosistemi (forse addirittura biomi?) per millenni o secoli in regresso a causa delle attività umane. Quarant’anni fa nessuno ci avrebbe scommesso. Ma l’Italia (come altri paesi europei) ha perso metà della superficie agricola dal 1960 a oggi. Dove l’uomo recede torna il bosco: gli Appennini erano terra di agricoltura e pastorizia marginale ma oggi – dopo 150 anni di spopolamento, di bastimenti per le Americhe o treni per le città del nord e quelle europee – sono una foresta senza soluzione di continuità. L’Unione Europea stima che, di circa 170 milioni di ettari di superficie agricola, 20 potrebbero venire abbandonati nelle zone rurali e montane del sud e dell’est del continente. Prendete qualunque foto delle Alpi di fine Ottocento, inizio Novecento, e noterete due differenze con oggi: ghiacciai in pauroso recesso e boschi lussureggianti al posto di versanti denudati dall’uso secolare del legno e dal pascolo. Il bosco ritorna: con il bosco, creature che credevamo di avere eliminato dalla faccia della terra (ma non dal nostro inconscio).
Cambiamento. Paura del cambiamento? Abbatteremo prima (di nuovo) l’ultimo lupo o dichiareremo prima estinto il buon latte di una volta? Nel mio supermarket metà del “latte” sugli scaffali è ormai di avena, mandorla, soia. Ma quello vero mi costa 4 miliardi di franchi all’anno di sussidi, anche se non sono d’accordo a pagarli e anche se è fonte di emissioni di gas-serra. Coesistenza? Una montagna per l’uomo, il latte e lo sci, e una per il lupo? È così difficile? A Yellowstone, dove il lupo è stato realmente reintrodotto e oggi prolifera, fanno 4 milioni di visitatori l’anno ma fuori dalle zone accessibili ai turisti non puoi andare: vieni fermato dai rangers (meglio per te) o come alternativa affrontato da mamma-grizzly. Cambiamenti. Nessuno li affronta volentieri ma niente dura per sempre, né noi né i lupi (li abbiamo già fatti fuori una volta) e il concetto di climax (equilibrio) degli ecosistemi non prevede quello di immutabilità. Le foreste sono andate e tornate, varie volte. La prossima generazione si dovrà domandare se, al posto degli abeti rossi, sarà meglio rimboscare le Alpi con pini d’Aleppo. E allevare zebù. Ma per i lupi, che già hanno ricolonizzato perfino i litorali laziali e i campi di mais padani, che sono arrivati alle periferie di Francoforte e Bruxelles e hanno attraversato tutta la Francia del sud dalle Alpi Marittime ai Pirenei, non so se questi saranno grossi problemi.
Mauro Balboni
Mauro Balboni, laureato in Scienze agrarie all’Università di Bologna, ha lavorato oltre 30 anni nella ricerca e sviluppo della grande industria agrochimica, la maggior parte dei quali come dirigente con responsabilità europee e globali. Ha vissuto a Milano, Bologna, Vienna, Oxford, Zurigo. Oggi risiede tra la Svizzera e il lago di Garda, dove ha trovato la sua vera life mission, quella di conservare un biotopo di prati magri e i suoi legittimi residenti: le “carote ametista”, le cavallette dalle ali blu, le api, le farfalle e le orchidee rare. Dal 2017 scrive sui temi della sicurezza alimentare globale e dell’impronta del cibo sulle risorse e gli ecosistemi, prima con “Il Pianeta mangiato” e ora con “Il pianeta dei frigoriferi“. Nel resto del suo tempo gira l’Europa con il camper, a piedi o in bicicletta anche alla ricerca di agricolture e di cibi presenti, passati e futuri.